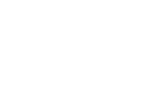In Argentina lungo il filo di cotone di un progetto ambizioso di commercio equo
Reportage di Sandra Cangemi – Coordinamento Nord/Sud del Mondo
Giugno 2008 – Questa storia nasce da una serie di incontri casuali. Come quello, nel 2002, tra Harold Picchi, un argentino in fuga dal default argentino, e la cooperativa di commercio equo milanese Chico Mendes. Da cui nasce un progetto che sembra delirante: una filiera tessile (quasi) tutta equa e solidale, nell’Argentina della crisi. Cominciamo dalla fine. Da chi le magliette di questa filiera le cuce.
Anche questo è stato un incontro fortuito. Ce lo raccontano le ragazze del laboratorio di cucito della cooperativa La Juanita, nata dal movimento dei disoccupati de La Matanza, barrio di un paio di milioni di abitanti a un’oretta di macchina da Buenos Aires (quando non piove: perché allora le strade diventano fiumi di fango e di ore ce ne vogliono tre, come è successo a noi). “Nel 2003, stavamo vendendo abiti di tessuti riciclati al mercato solidale di Palermo Viejo (un quartiere di Baires, ndr) e abbiamo incontrato Harold Picchi, che ci ha parlato del progetto. Il laboratorio era nato due anni prima, con un corso di formazione gratuita dell’Università di San Martin. Non avevamo nemmeno le macchine per cucire, le prime tre ce le ha regalate l’ambasciata svizzera. I primi anni cucivamo insieme pezzetti di stoffa riciclata per fare indumenti e coperte.
Per nostra fortuna, abbiamo incontrato molti sognatori. Tra questi appunto Harold, che ci ha aiutato a rafforzarci, a lavorare sui punti critici e a imparare a produrre magliette adeguate al gusto europeo, molto esigente. Il nostro motto? “Rendiamo il lavoro di moda”. L’abbiamo scritto anche su alcune magliette”. L’impegno per la dignità del lavoro e per l’autogestione, il rifiuto di ogni forma di clientelismo e assistenzialismo e la passione per l’educazione alla libertà sono i capisaldi della cooperativa La Juanita, che ha sede in una ex scuola e gestisce anche una casa editrice, un asilo, una panetteria popolare con annessa scuola, un laboratorio di riciclaggio di computer e formazione informatica, un circuito di microcredito, corsi di alfabetizzazione per adulti, un laboratorio di stampa di tessuti.
Anche la cooperativa tessile Juana Azurduy (22 soci in tutto; gestiscono anche una panetteria e una pizzeria e lavorano il ferro)ha sede in una scuola abbandonata di La Plata, città universitaria nei dintorni di Buenos Aires. Pareti coperte di murales, due stanzoni pieni di stoffe e macchine per cucire. Sette ragazze: interrompono il lavoro per raccontarci la loro avventura bevendo mate. “Le macchine le abbiamo comprate con un piccolo finanziamento a fondo perduto del governo federale. Abbiamo iniziato in tre, due anni fa, cucendo grembiuli, uniformi scolastiche e t-shirt che vendevamo alla Sur, la serigrafia di un’altra associazione. E’ grazie alla Sur che abbiamo conosciuto il commercio equo. Ci è sembrato perfetto: proprio quello che cercavamo. Vogliamo un’economia dove le persone sono più importanti dei soldi, senza padroni, che lavori in rete e in solidarietà con altri gruppi del movimento. Non vogliamo produrre per l’economia “normale”, anche se questo vuol dire guadagnare solo il minimo per sopravvivere, per ora”. Le ragazze hanno sistemato le macchine in modo da potersi guardare in faccia, e devono puntare la sveglia sull’orario di uscita perché altrimenti si scorderebbero di andare a casa; mentre lavorano sono praticamente in assemblea permanente, perché qui si decide tutto insieme. “Sotto padrone nulla è tuo, qui invece tutto è nostro. Vuol dire più responsabilità, impegno reciproco, rispetto delle colleghe ma anche dei compagni del movimento, di Altromercato… Ora stiamo cercando di aiutare l’avvio di altri laboratori nel quartiere: diamo formazione, prestiamo le nostre macchine e aiutiamo per la distribuzione dei prodotti”. Risaliamo la filiera scendendo a sud per 600 chilometri. La Textiles Piguè, dove si producono i tessuti per le magliette, è in piena pampa, in una cittadina di 15mila abitanti. La Textiles è una delle 220 imprese recuperate argentine: portate al fallimento da imprenditori irresponsabili, occupate e rimesse in produzione dai lavoratori costituiti in cooperativa, che hanno resistito a una denuncia per usurpazione, a un violento sgombero, al tentativo di acquisto da parte di un fondo finanziario americano, fino a ottenere una sentenza di esproprio temporaneo. L’organizzazione del lavoro, gli investimenti, i salari (quello di base, 800 pesos, è uguale per tutti, poi ci sono indennità di responsabilità, fino a un massimo di 1.100) vengono decisi dall’assemblea dei 130 soci lavoratori, che eleggono anche il Cda, “i cui sette membri sono pagati meno”, spiega il presidente, Francisco Martinez, “perché è un ruolo di servizio, non di potere”. Si lavora in gruppi, ognuno con un responsabile. In quattro anni non c’è stato nessun incidente grave: le norme sulla sicurezza vengono rigorosamente rispettate. E non si scaricano più nel fiume i residui di lavorazione, come quando c’era il padrone; ora c’è il depuratore. Il 5, 6% della produzione è per il commercio equo, ma l’impresa lavora al 30% circa delle sue potenzialità, solo con filati forniti dai committenti, perché l’accesso al credito è un grosso problema. In via di superamento, però: la Textiles è la prima fabbrica recuperata argentina che nel febbraio 2008 ha firmato un accordo con la ministra della produzione per acquistare l’impresa in 10 anni, a un tasso bassissimo (9% annuo, con un’inflazione al 22), grazie a un fondo di fideiussione costituito da Credicoop (una banca cooperativa argentina) e dallo stesso ministero della produzione; altri fondi verranno dalla vendita di un terreno. Potrebbe essere un’esperienza pilota che apre la strada a una legge di espropriazione definitiva e a un fondo agevolato per imprese recuperate. “Il mio sogno”, dice Martinez, “è poter arrivare a salari dignitosi e all’accesso al credito, e poter mettere un giorno la mia esperienza a disposizione della società. Il lavoro nella filiera tessile, il lavoro con i disoccupati organizzati e con i campesinos è già parte di questo sogno”.
A questo punto la filiera salta un anello. I filati vengono prodotti da un’impresa vicina a Buenos Aires che rispetta i criteri della responsabilità socio-ambientale, ma niente di più. “Si tratta di produzioni industriali, dove per ora è praticamente impossibile trovare aziende eque”, spiega Picchi. E anche la tracciabilità dei filati, ufficialmente garantita, non è poi così certa.
Risaliamo verso nord per 1.800 km e arriviamo in Chaco, una delle province più povere. Sono gli indigeni Toba della Union Campesina a produrre il cotone biologico (e di ottima qualità) per le magliette, tra mille difficoltà. Le sementi vengono fornite dal governo provinciale, ma non sempre sono di buona qualità. E mancano macchinari, attrezzi, mezzi di trasporto. Molti non hanno nemmeno il titolo di proprietà delle terre su cui vivono, a causa delle lentezze burocratiche. Non si può fare la rotazione delle colture, anche se eviterebbe l’impoverimento del terreno, perché il governo sussidia solo il cotone. Mancando un ente commerciale in grado di fatturare, anche per l’opposizione dei funzionari del governo provinciale, finora gli indigeni non sono riusciti a ottenere né un vero e proprio contratto, né un prefinanziamento. La grande paura degli indigeni è quella di perdere la terra, cedendo all’offensiva dei latifondisti che producono soia, e ridursi a braccianti. “Il commercio equo ha evitato peggioramenti, ma per adesso non ha ancora prodotto miglioramenti evidenti; del resto, il progetto è iniziato da poco”, spiega Luis Skupien, agronomo e responsabile del progetto in Chaco. “In più, la richiesta sta diminuendo: nel 2008 sono previste solo 90 tonnellate. Ma il problema di base è l’equa distribuzione e la proprietà della terra e degli strumenti di produzione”. Nei campi è iniziato il raccolto: donne e uomini chini sotto il sole nei campi vicino a casa, che può essere una capanna di terra battuta, mattoni e legno o di rami e stracci. Alcuni coltivano mais, manioca, batate e allevano galline, capre o vacche. “Siamo al secondo raccolto”, spiega Esther, sette figli, “ma forse quest’anno non ce ne saranno altri, il seme non è buono. “E per poter comprare i vestiti e le scarpe per mandare a scuola i figli dobbiamo arrivare al quarto, quinto raccolto”.