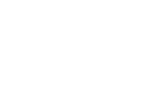Esattamente sette anni fa, il 24 aprile 2013, 1.134 lavoratori hanno perso la vita nel peggiore incidente che si ricordi nella storia dell’industria dell’abbigliamento. Oggi, mentre commemoriamo le vittime del crollo del Rana Plaza e rivolgiamo un pensiero a tutte le persone colpite da questa tragedia, la vita dei lavoratori è ancora una volta in pericolo. In Bangladesh, la crisi che ha investito l’industria dell’abbigliamento in seguito alla pandemia da Covid-19 indebolisce i lavoratori nella lotta incessante per ottenere maggiori diritti: sistemi di protezione sociale, salari dignitosi, libertà di organizzazione sindacale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Esattamente sette anni fa, il 24 aprile 2013, 1.134 lavoratori hanno perso la vita nel peggiore incidente che si ricordi nella storia dell’industria dell’abbigliamento. Oggi, mentre commemoriamo le vittime del crollo del Rana Plaza e rivolgiamo un pensiero a tutte le persone colpite da questa tragedia, la vita dei lavoratori è ancora una volta in pericolo. In Bangladesh, la crisi che ha investito l’industria dell’abbigliamento in seguito alla pandemia da Covid-19 indebolisce i lavoratori nella lotta incessante per ottenere maggiori diritti: sistemi di protezione sociale, salari dignitosi, libertà di organizzazione sindacale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pandemia da coronavirus mette a rischio le conquiste fin qui ottenute a caro prezzo dai lavoratori dai tempi del Rana Plaza
In un momento di crisi senza precedenti per l’industria dell’abbigliamento, che vede il prosciugarsi della domanda, gli ordini annullati o differiti, e milioni di lavoratori affrontare lo spettro dell’indigenza, è di vitale importanza che non vadano perse le forme di tutela tanto faticosamente conquistate. Se le catene di fornitura torneranno a ricomporsi dopo la fine della pandemia, esse dovranno farsi guidare dagli insegnamenti che vengono dalla tragedia del Rana Plaza e dall’esperienza maturata con la crisi in corso. La strada da intraprendere è verso un’industria improntata a maggiore sicurezza ed equità, governata da regole vincolanti ed esigibili sui grandi temi del salario, della salute e della sicurezza, della libertà di associazione e delle tutele sociali. Niente deve tornare ad essere com’era prima del 2020 e neppure del 2013.
Dal maggio 2013, l’Accordo per la prevenzione contro gli incendi e sulla sicurezza degli edifici in Bangladesh, istituito in risposta alla tragedia del Rana Plaza, è riuscito a garantire luoghi di lavoro più sicuri per oltre 2 milioni di persone. L’accordo copre più di 1.600 fabbriche presso le quali è stato possibile porre rimedio al 91% di tutti i difetti di sicurezza riscontrati nel corso di ispezioni regolarmente programmate. Nel maggio 2019, una lunga battaglia legale sul diritto dell’Accordo di continuare ad operare in Bangladesh si è risolta con l’intesa che nell’arco di un anno le funzioni dell’Accordo sarebbero state trasferite al cosiddetto “RMG Sustainability Council” (RSC), un organismo partecipato dalla Bangladesh Garment Manufacturer and Exporter Association (BGMEA), associazione che rappresenta i titolari delle fabbriche.
Le organizzazioni a difesa dei diritti dei lavoratori dentro e fuori il paese, fra queste la Clean Clothes Campaign, ripetono da tempo che non può essere avviato nessun nuovo programma se prima non sono stati portati a termine gli obiettivi precedentemente fissati. Per essere efficace l’azione dell’RSC deve proseguire nel solco dell’Accordo e fare propri i suoi aspetti fondanti, con particolare riguardo ai criteri dell’obbligatorietà e della trasparenza, che andranno inseriti in un accordo internazionale da far sottoscrivere alle imprese del settore, insieme all’impegno a garantire condizioni contrattuali che consentano ai fornitori di sostenere i costi degli interventi correttivi nelle fabbriche.
Con il diffondersi della pandemia le trattative per arrivare a un’intesa si sono interrotte e l’Accordo ha sospeso la usa operatività. Mentre la data di inizio delle sue attività si avvicina, manca quasi del tutto la garanzia che l’RSC saprà svolgere un’azione di tutela efficace per i lavoratori, anche a giudicare dall’assenza di un elemento decisivo, e cioè l’impegno delle imprese a offrire ai fornitori condizioni contrattuali commisurate ai costi degli adempimenti. È pertanto di fondamentale importanza ripristinare e concludere il processo di elaborazione di un accordo internazionale legalmente vincolante che racchiuda tale impegno, così come deve essere completato il lavoro dell’Accordo prima che l’RSC ne prenda il posto. In mancanza di questo, l’RSC non si distinguerà nel suo operare dalle tante iniziative volontarie che non hanno saputo impedire il crollo del Rana Plaza.
In questi ultimi sette anni, anche grazie al contributo fattivo di numerosi rappresentanti del mondo delle imprese, è stato possibile instituire in Bangladesh un sistema assicurativo volto a garantire sostegno economico ai lavoratori vittime di infortuni e alle famiglie di chi ha perso la vita sul lavoro. Un’iniziativa di questa portata, che ha suscitato tante attese, non deve essere ulteriormente posticipata. Sette anni dopo il crollo del Rana Plaza, al dolore delle famiglie colpite dalla disabilità o dalla morte dei propri cari non deve aggiungersi anche il dramma dell’indigenza.
La crisi che stiamo attraversando dovrebbe servire di ulteriore stimolo al rafforzamento delle misure di protezione sociale, in linea con gli standard dell’OIL in tema di indennità per malattia, disoccupazione e assistenza sanitaria. Il governo del Bangladesh deve porsi alla guida di questo processo il quale, tuttavia, non può prendere avvio senza una condivisione dei costi fra tutti i soggetti che comporranno le future filiere produttive.
Ordini annullati e chiusure delle fabbriche minacciano il futuro dell’industria dell’abbigliamento
L’assenza di solidi sistemi di sicurezza sociale e la disparità di poteri che caratterizzano le catene di fornitura sono venute dolorosamente allo scoperto con la pandemia da coronavirus. Dopo un iniziale rallentamento della produzione provocato dalla scarsità di materie prime di provenienza cinese, l’industria ha risentito notevolmente della cancellazione degli ordini da parte degli acquirenti occidentali e della determinazione dei marchi di non piazzarne di nuovi. Una ricerca condotta dal Penn State Center for Global Workers’ Rights indica che alla fine del mese di marzo quasi la metà delle fabbriche si è vista annullare buona parte degli ordini quasi pronti per la spedizione.
L’indignazione suscitata da queste notizie ha convinto alcuni acquirenti a rivedere la loro decisione e ad accettare di pagare per gli ordini già in produzione. Un numero rilevante di grandi marchi acquirenti, in particolare Arcadia, Gap, Walmart, Tesco, ma non solo, si mostra irremovibile e rifiuta di pagare e di ricevere gli ordini completati anche a costo di violare i contratti di commessa. A fare le spese di comportamenti così irresponsabili sono in ultima analisi i lavoratori.
Dopo l’annuncio dato dal governo il 25 marzo del lockdown generale con scadenza il 4 aprile, molte fabbriche di confezioni hanno chiuso e migliaia di lavoratori sono rientrati ai loro villaggi dalle famiglie. Gli imprenditori non avevano l’obbligo di sospendere le attività ed è per questo che un numero non trascurabile di fabbriche ha continuato a operare. Al termine del periodo di chiusura forzata, migliaia di persone si sono rimesse in cammino verso le città per ritornare al lavoro e ritirare la busta paga di marzo, percorrendo la distanza a piedi o con mezzi di fortuna a causa del blocco dei mezzi pubblici. Una volta arrivati, e solo in quel momento, sono stati informati che la chiusura era stata prorogata o che erano stati licenziati, quasi tutti senza neppure ricevere gli arretrati del mese di marzo.
“I lavoratori sono rientrati nei luoghi di lavoro correndo seri rischi per la loro sicurezza e spendendo molti soldi per il trasporto”, ha detto Kalpona Akter, presidentessa della Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation, “Le decisioni irrazionali dei proprietari delle fabbriche non hanno messo a rischio solo la vita dei dipendenti ma quella dell’intera popolazione. La notizia del controesodo forzato dei lavoratori ha fatto discutere a livello nazionale e solo allora le organizzazioni datoriali BGMEA e BKMEA si sono convinte a concedere alle aziende associate un periodo di sospensione generale delle attività”.
Nonostante la proroga delle misure restrittive decisa dal governo, alcune fabbriche hanno riaperto obbligando i dipendenti a rientrare sotto la minaccia del licenziamento o della perdita dei salari arretrati. La BGMEA ha ribadito l’intenzione di riaprire tutte le fabbriche dopo il 25 aprile. I lavoratori non devono correre rischi per la loro salute e sicurezza da una riapertura frettolosa. In questo periodo di emergenza sanitaria spetta ai datori di lavoro garantire il benessere dei loro dipendenti, corrispondere per intero le retribuzioni dovute mediante i sistemi digitali predisposti dal governo, cessare i tagli di personale, reintegrare chi è stato licenziato all’inizio della pandemia e, quando si potrà riprendere il lavoro in sicurezza, fornire adeguate misure di protezione e congedi per malattia.
È compito del governo favorire la creazione di sistemi di protezione sociale per i lavoratori estendendone gli effetti a chi è stato licenziato o messo in congedo non retribuito, e vigilare affinché le erogazioni avvengano sotto la responsabilità dei datori di lavoro e delle imprese acquirenti in modo trasparente e con verifiche indipendenti.
I marchi e i distributori non si sono assunti le loro responsabilità, disinteressandosi della sopravvivenza economica dei lavoratori, e non sono intervenuti nei confronti delle imprese fornitrici per impedire iniziative sconsiderate. Al contrario, con il loro rifiuto di pagare gli ordini già in lavorazione e il tentativo di giocare al ribasso sui prezzi, hanno messo i partner commerciali in difficoltà, lasciando loro poco margine per il pagamento delle retribuzioni di marzo e dei mesi a venire. I marchi hanno il dovere di assicurare il pagamento degli ordini e garantire, insieme con i fornitori, la corresponsione delle retribuzioni per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, per non abbandonare i lavoratori all’indigenza e senza garanzie occupazionali.
La crisi mostra tragicamente che i sette anni trascorsi non sono riusciti a modificare le disparità di potere esistenti fra i lavoratori e i datori di lavoro. I dipendenti delle fabbriche ospitate nel Rana Plaza erano consapevoli del pericolo che correvano entrando quel tragico giorno nell’edificio in cui lavoravano, ma era più forte la paura di perdere un mese intero di salario perché questa era la minaccia dei loro superiori. Ancora oggi milioni di lavoratori sono messi di fronte alla scelta impossibile fra la salute e la sopravvivenza. Altri saranno nuovamente obbligati a presentarsi al lavoro nella consapevolezza che potrebbero perdere la vita. Per come sono costruite le catene di fornitura è facile per i datori di lavoro, gli acquirenti e i governi scaricare le responsabilità per qualsiasi danno subisca un lavoratore, così com’è avvenuto dopo il crollo del Rana Plaza. È arrivato il momento che i soggetti economici e decisionali di queste filiere si impegnino in un programma comune a sostegno dei diritti dei lavoratori.
Proteste salariali
Esasperati dall’insicurezza, dai salari non pagati e dai licenziamenti, i lavoratori sono scesi per le strade a protestare. È soprattutto a partire dal 12 aprile che si sono intensificati i sit-in e le manifestazioni partecipati da centinaia di persone che reclamavano la fine dei licenziamenti e il pagamento dei salari arretrati. Le proteste sono cresciute dopo che si è avuta notizia che centinaia di imprenditori hanno ignorato una disposizione del governo che prevedeva sanzioni per chi non avesse provveduto al pagamento dei salari prima del 16 aprile, e che garantiva prestiti agli imprenditori impossibilitati a far fronte ai loro obblighi.
Le proteste di piazza sono all’ordine del giorno in Bangladesh. Nonostante sia sotto gli occhi di tutti la necessità di risolvere il problema annoso degli abusi nell’industria dell’abbigliamento dopo la tragedia del Rana Plaza, ogni tentativo fatto dai lavoratori per organizzarsi viene represso con ogni mezzo perché solo mantenendo in piedi un sistema ingiusto, che si rivale sui salari, è possibile per gli attori economici continuare ad estrarre i profitti spropositati a cui sono abituati. Nel gennaio 2019 un giro di vite di proporzioni inaudite si è abbattuto sui lavoratori che si erano mobilitati in proteste pacifiche contro i salari da fame. Più di 10 mila persone sono state licenziate, molte altre sono finite in una lista nera, e sulla base di false accuse migliaia di persone sono state denunciate. In questo momento ci sono almeno venti casi in attesa di giudizio che coinvolgono centinaia di lavoratori sui quali incombe il rischio della prigione. A questi si aggiungono altri tre procedimenti penali avviati nei confronti di alcuni dirigenti sindacali per punirli del ruolo svolto nell’organizzazione delle proteste del 2016.
Quando gli edifici pubblici riapriranno, i lavoratori denunciati dovranno recarsi regolarmente in tribunale per le pratiche da sbrigare, come avveniva prima dell’emergenza sanitaria, e questo li esporrà a nuovi rischi oltre a quelli già affrontati durante la pandemia. La minaccia dell’incarcerazione accresce inoltre il livello di insicurezza percepito. È pertanto di fondamentale importanza che i casi vengano trattati immediatamente dai tribunali e che le false accuse formulate vengano respinte. Sta ai marchi, ai proprietari delle fabbriche e alle autorità agire con tempestività affinché le denunce siano ritirate e sia garantita ai lavoratori la libertà di associazione.
Amin Amirul Haque, presidente della National Garment Workers Federation, così conclude: “Le disuguaglianze presenti nelle filiere produttive globali, che adesso l’emergenza da Covid-19 ha amplificato, sono sempre esistite. È impensabile che dopo la ripresa si possa tornare alla normalità degli affari come se nulla fosse accaduto. È arrivato il momento che i marchi e i distributori mettano mano a una riforma radicale delle loro filiere e nel far questo devono dare la precedenza ai diritti dei lavoratori facendo propri i criteri della sicurezza sociale e dei salari dignitosi mediante meccanismi vincolanti e trasparenti”.
Note
- Worker Rights Consortium tiene traccia di quali imprese dell’abbigliamento si impegnano a rispettare il pagamento degli ordini e quali rifiutano di farlo: https://www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/.
- Clean Clothes Campaign gestisce un live blog che raccoglie informazioni su come la pandemia da Covid-19 ha condizionato la vita dei lavoratori: https://cleanclothes.org/news/2020/live-blog-on-how-the-coronavirus-influences-workers-in-supply-chains. La rete della CCC ha pubblicato un elenco di richieste rivolte alle imprese acquirenti, ai proprietari delle fabbriche e ai governi: https://cleanclothes.org/news/covid-19-short-term-demands-in-defense-of-garment-workers-in-global-supply-chains
- Il comportamento delle imprese acquirenti e dei proprietari delle fabbriche rispetto alla repressione sociale e sindacale del 2018-2019 è monitorato da International Labor Rights Forum: https://laborrights.org/2019-crackdown-your-favorite-brand-complicit.